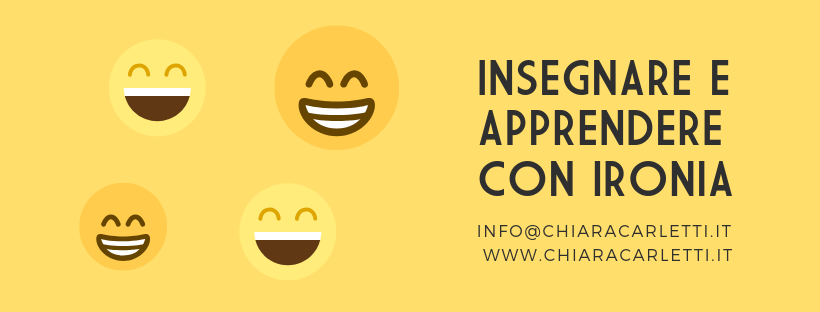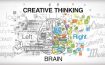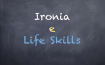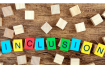Cos’è la cultura?
L’antropologo vittoriano Edward Burnett Tylor nel 1871 nel suo celebre libro “Primitive Culture” scrisse:
«La cultura, o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell’insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società».
Questa è una delle tante, probabilmente la più conosciuta, delle oltre 525 definizioni di cultura date nel corso dei decenni dagli studiosi di scienze sociali. Personalmente mi sento di condividere quella dell’antropologo Marco Aime, secondo il quale la cultura è “ciò che ci tiene insieme”.

La cultura ci fa sentire parte di un gruppo e – di conseguenza – tutto ciò che appare diverso rispetto agli usi e costumi nei quali ci riconosciamo, viene guardato con timore e, talvolta, addirittura allontanato. Nel rivendicare la “nostra” cultura, questa viene considerata come qualcosa di originario, immutabile, essenziale. Così intesa appare però come un “imbroglio” (Fabietti, 2000). Non esistono infatti culture pure, queste sono incomplete, aperte allo scambio, all’incrocio e all’ibridazione. Sono mescolate, contaminate l’una con l’altra. Da sempre. Le culture sono degli ibridi che possono essere compresi solo da una prospettiva in grado di far propria una “logica meticcia” (Amselle, 1999).
La cultura andrebbe dunque pensata non come uno stato mentale, bensì come una costruzione sociale, va messo l’accento sul suo dinamismo, sulla mutevolezza, sull’instabilità, sul suo carattere relazionale: la sua forza agisce infatti non solo sugli attori sociali, ma può anche essere agita e trasformarsi.
Altri studiosi ritengono la cultura una sorta di seconda natura che gli uomini hanno per abitare il mondo. Molti studiosi concordano infatti nel sostenere l’incompletezza biologica dell’uomo, il quale ha bisogno della cultura per sopravvivere. Non solo gli individui non possono fare a meno della cultura, questa è essenziale anche per la sopravvivenza delle società. Quest’ultime infatti, per continuare ad esistere e per preservare l’identità dei propri membri, attribuiscono a certe norme, valori e simboli un carattere naturale, se non addirittura sacro. Ciò le rende un vero e proprio strumento politico usato per delimitare dei confini, alzare dei muri, rivendicare diritti o presunti tali, creare differenze, intolleranze e discriminazioni. Di qui l’importanza dell’antropologia, ovvero di un sapere in grado di andare oltre certe banalizzazioni, per educare menti aperte e flessibili e formare cittadini critici e liberi. Lo studio di questa disciplina consente di cogliere il carattere situato e costruito di tutto ciò che ruota intorno all’uomo: da ciò che lo riguarda da vicino, ovvero identità, emozioni, idee, corpo, a ciò che è esterno all’individuo, come ad esempio la cultura, la quale viene dagli individui costruita, prodotta, agita e trasformata in riferimento a numerose variabili.